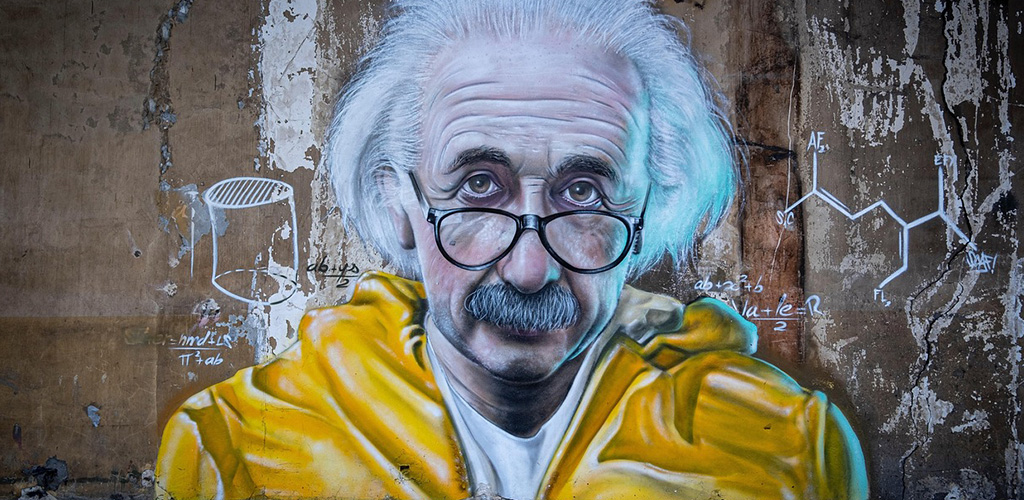Gehlbach, Robinson e Fletcher, tre psicologi d’Oltreoceano, hanno descritto in un loro studio, basato su un campione di 1501 utenti della piattaforma “Prolific”, pubblicato sulla rivista scientifica “Plos One” nell’ottobre dello scorso anno, un bias cognitivo denominato “Illusione dell’adeguatezza dell’informazione”, ovvero un’euristica che induce le persone a ritenere di possedere sufficienti informazioni per comprendere una situazione e assumere conseguenti decisioni, anche quando l’acquisizione è soltanto parziale.
Questa distorsione cognitiva è spesso collegata con il “bias del realismo ingenuo” che porta gli individui a ritenere che la loro interpretazione soggettiva di una determinata situazione corrisponda alla verità oggettiva. Ne sono prova evidente tutte le fake news fatte circolare in prossimità delle elezioni negli Stati Uniti o, di recente, sulla salute del papa.
Si tratta di preconcetti che oggi più che mai stanno avvelenando i pozzi dell’informazione e alimentando la polarizzazione nei social. Anche gli scambi tra studenti universitari non ne sono esenti: dalla condivisione di informazioni parziali e frammentate nei lavori di gruppo sino alla scarsa apertura al confronto con visioni e prospettive diverse dalle proprie. Una carenza sottolineata da un paper di Wineburg e McGrew, pubblicato nel 2017, che evidenzia come spesso anche nell’ambito della ricerca ci siano soggetti che si accontentano dei primi risultati restituiti da Google Scholar o altri motori dedicati all’approfondimento accademico, senza interrogarsi su quali informazioni potrebbero mancare o quali studi potrebbero realmente completare in maniera adeguata la propria indagine.
Antidoti efficaci per contrastare questi bias ce ne sono: dall’adottare metodi di verifica rigorosi a confrontarsi con altri punti di vista, senza preconcetti, cercando di acquisire il maggior numero di informazioni possibili. Processi non banali che richiedono un carico energetico molto superiore a quello delle scorciatoie mentali e, pertanto, spesso evitati dal nostro cervello che tende a privilegiare soluzioni rapide e poco dispendiose.
Marco Sanavio direttore #CubeLive